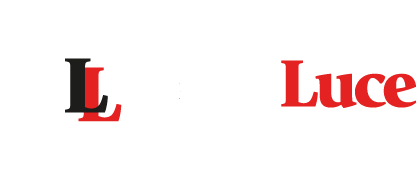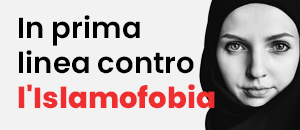L’esercito israeliano ha lanciato una nuova operazione militare via terra a Gaza, mirata alla riconquista del corridoio di Netzarim, un’area strategica che divide la Striscia di Gaza in due tronconi, bloccando il transito tra il nord e il sud. Questo corridoio era stato abbandonato dalle forze israeliane come parte di un accordo per il cessate il fuoco nel gennaio scorso, consentendo il ritorno a casa di migliaia di palestinesi sfollati. Tuttavia, con la ripresa delle ostilità, l’area è diventata nuovamente una zona di conflitto.
Secondo il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, l’operazione rappresenta un “ultimo avviso” a Hamas per accettare la proposta negoziale avanzata dagli Stati Uniti, che prevede la liberazione di ostaggi israeliani in cambio della cessazione delle ostilità. Tuttavia, Hamas ha dichiarato di non aver chiuso la porta al dialogo, ribadendo la volontà di negoziare senza condizioni preliminari, pur chiedendo un immediato cessate il fuoco.
Raid aerei e morti civili
L’invasione via terra da parte dell’esercito israeliano è stata accompagnata da una serie di raid aerei devastanti che hanno colpito numerosi obiettivi nella Striscia di Gaza, provocando centinaia di morti e feriti tra la popolazione civile. Le operazioni militari hanno colpito non solo aree ritenute strategiche ma anche zone residenziali e luoghi considerati sicuri, rendendo ancora più drammatica la situazione umanitaria.
Uno degli episodi più tragici si è verificato a Khan Younis, dove un bombardamento ha causato la morte di Lubna al-Najjar, una giovane madre che si trovava all’interno di una tendopoli allestita per gli sfollati. La scena è stata immortalata dalle telecamere locali, mostrando il piccolo Izzam Wadi, il figlio di Lubna, visibilmente scosso e impolverato, mentre seguiva la preghiera accanto alla bara della madre. Una scena simbolo della disperazione che travolge Gaza, dove le vittime non sono solo numeri, ma storie spezzate e vite distrutte.
Non lontano da Khan Younis, nella cosiddetta zona umanitaria di al-Mawasi, un’altra tragedia ha colpito la famiglia di Alaa Abu Helal. Alaa ha perso il figlioletto Mohammed, di appena un anno e un mese, insieme alla moglie incinta di sette mesi. Entrambi sono stati uccisi durante un bombardamento aereo che ha trasformato la zona in un cumulo di macerie e sangue. Il dolore di Alaa si è riversato in poche parole strazianti: “Mia moglie è nata il 20 febbraio, mio figlio è nato il 20 febbraio. Mia moglie è morta il 19 marzo, mio figlio è morto il 19 marzo”. Parole che risuonano come un grido di dolore che attraversa i confini e scuote le coscienze.
Nel quartiere di al-Sultan, un attacco aereo ha colpito un’abitazione utilizzata per celebrare un funerale, causando la morte di 14 persone. Tra le vittime, un bambino di appena due anni e mezzo, Omar Abu Sharqiyya, ucciso da un drone mentre si trovava ad Asraa City. Poco dopo, un raid contro un’auto a Rafah ha provocato la morte di cinque persone, tra cui alcuni giovani del luogo. Un altro attacco ha colpito un appartamento ad Al-Rimal, uccidendo tre membri della stessa famiglia, mentre nella casa della famiglia Kilani a Beit Lahiya altre tre persone sono rimaste uccise.
Tra le storie più drammatiche c’è quella di Ramy Abdu, fondatore dell’ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, che ha appreso telefonicamente dalla sua base europea della morte dell’intera famiglia: la sorella Nesreen, il cognato Mohammed e i loro tre figli, Ubaida, Omar e Layan. Una notizia che ha spezzato il cuore di chi, da anni, si batte per i diritti umani e per la fine delle violenze nella regione.
Il bilancio delle vittime continua a crescere di ora in ora. Secondo gli ultimi dati disponibili, dal 18 marzo si contano 436 morti, di cui 183 bambini e un centinaio di donne. I bombardamenti indiscriminati stanno trasformando Gaza in un inferno a cielo aperto, mentre i familiari delle vittime cercano disperatamente i corpi tra le macerie.
Gli attacchi non risparmiano nemmeno i luoghi di rifugio. In molti casi, le tende utilizzate dagli sfollati come riparo temporaneo si sono trasformate in trappole mortali. Le immagini dei bambini feriti, delle famiglie distrutte e delle case ridotte in polvere stanno facendo il giro del mondo, suscitando indignazione e proteste internazionali. Ma la macchina bellica non sembra fermarsi, e l’offensiva via terra si intensifica giorno dopo giorno, sostenuta da una retorica politica che giustifica l’uso della forza come misura necessaria per garantire la sicurezza di Israele.
La popolazione palestinese è intrappolata tra le bombe e la disperazione, senza alcun luogo sicuro dove rifugiarsi. I pochi ospedali ancora operativi sono al collasso, sovraffollati da feriti gravi e con scorte mediche sempre più esigue. Gli operatori umanitari denunciano la difficoltà di portare aiuti essenziali, mentre le vie di accesso alla Striscia restano sigillate.
Bombardamenti contro l’ONU
Tra le tragiche conseguenze dell’offensiva israeliana su Gaza si annoverano anche i bombardamenti contro strutture delle Nazioni Unite, un fatto che ha scatenato una forte condanna internazionale. Uno degli episodi più gravi si è verificato a Deir al-Balah, dove un attacco aereo ha colpito una guest house utilizzata dai funzionari dell’UNOPS (Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti). L’attacco ha provocato la morte di due operatori umanitari e il ferimento di altri quattro. Nonostante le smentite del governo israeliano, che ha negato ogni responsabilità, l’episodio ha sollevato un’ondata di indignazione e ha attirato pesanti critiche da parte della comunità internazionale.
Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha espresso un’aspra condanna, denunciando l’episodio come una violazione grave del diritto internazionale e un atto inaccettabile contro i civili e il personale umanitario. Tuttavia, il governo israeliano ha reagito con veemenza, accusando Guterres di “bancarotta morale” per aver puntato il dito contro Israele senza tenere conto, a loro dire, della minaccia rappresentata da Hamas. Le dichiarazioni del premier israeliano e dei vertici militari continuano a respingere ogni accusa, affermando che l’attacco potrebbe essere stato causato da errori operativi o da lanci di razzi palestinesi deviati.
Non è la prima volta che strutture delle Nazioni Unite vengono colpite durante i conflitti nella Striscia di Gaza, ma questo nuovo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli operatori umanitari e sulla necessità di rispettare il principio di “deconflittualità” delle installazioni ONU, considerate zone neutrali e sicure anche in contesti bellici. Il direttore esecutivo dell’UNOPS, Jorge Moreira da Silva, ha sottolineato come la struttura colpita fosse stata notificata come area protetta alle forze israeliane nei giorni precedenti, ribadendo l’assoluta mancanza di giustificazioni per un attacco del genere.
Da Silva ha inoltre riferito che nei giorni precedenti erano già stati registrati altri due attacchi nelle vicinanze della guest house, segnalati alle autorità israeliane per evitare ulteriori violenze. Nonostante le comunicazioni ufficiali e le garanzie fornite, il raid è avvenuto senza preavviso, gettando un’ombra cupa sulla capacità dell’esercito israeliano di distinguere tra obiettivi militari e civili. Le strutture colpite erano chiaramente contrassegnate e note alle forze israeliane, come confermato dagli stessi operatori dell’ONU.
Di fronte alle accuse, il governo israeliano mantiene una posizione difensiva e continua a ribadire la legittimità delle proprie azioni militari, giustificandole con la necessità di neutralizzare le minacce terroristiche. Tuttavia, la comunità internazionale, comprese alcune alleate tradizionali di Israele, ha espresso forte preoccupazione per la crescente perdita di vite umane e per l’attacco diretto alle strutture umanitarie.
Le Nazioni Unite, attraverso i propri portavoce, hanno chiesto un’indagine indipendente per chiarire le circostanze dell’attacco e garantire la protezione dei civili e degli operatori umanitari. Tuttavia, finora non si registrano segnali concreti di collaborazione da parte israeliana, mentre l’offensiva militare continua senza sosta, e il bilancio delle vittime si aggrava di ora in ora.
Proteste interne in Israele
Mentre l’esercito israeliano intensifica l’offensiva a Gaza, sul fronte interno si moltiplicano le proteste contro il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Decine di migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di Tel Aviv e Gerusalemme, esprimendo apertamente il loro dissenso contro le politiche autoritarie e militariste dell’esecutivo. Le manifestazioni, nate inizialmente come reazione al licenziamento del capo dello Shin Bet, Ronen Bar, si sono rapidamente trasformate in un movimento di protesta più ampio contro la gestione autoritaria del paese e la crescente militarizzazione della società israeliana.
A Tel Aviv, le proteste si sono concentrate principalmente davanti alla residenza ufficiale del primo ministro, mentre a Gerusalemme i manifestanti si sono radunati nelle piazze principali e nelle strade adiacenti. La polizia ha risposto con un massiccio dispiegamento di forze, utilizzando idranti, gas lacrimogeni e, in alcuni casi, cariche per disperdere la folla. Alcuni manifestanti hanno riportato ferite e si registrano almeno quattro arresti. La repressione delle proteste ha attirato critiche da parte di diverse organizzazioni per i diritti umani, che hanno denunciato un uso eccessivo della forza e la limitazione della libertà di espressione.
Il licenziamento di Ronen Bar, capo dei servizi segreti interni, è stato percepito come un atto di consolidamento del potere da parte di Netanyahu, intento a eliminare figure scomode all’interno dell’apparato di sicurezza nazionale. Questo evento ha suscitato indignazione anche tra i membri della comunità della sicurezza e dell’intelligence, molti dei quali hanno espresso preoccupazione per la politicizzazione delle istituzioni statali e il rischio di una pericolosa deriva autoritaria.
Le proteste non riguardano solo la destituzione di Bar, ma anche il ritorno nel governo di Itamar Ben-Gvir, politico ultranazionalista e figura controversa della destra israeliana. La sua riammissione nell’esecutivo ha consolidato la maggioranza governativa, ponendo fine all’instabilità politica che minacciava la sopravvivenza del governo in vista dell’importante voto sul bilancio della settimana successiva. Tuttavia, la sua presenza ha suscitato ulteriore malcontento tra i settori più moderati della società israeliana e persino tra alcuni membri della coalizione stessa, che vedono nell’ascesa di Ben-Gvir un ulteriore passo verso la radicalizzazione delle politiche governative.
Il contesto socio-politico all’interno di Israele è reso ancora più complesso dall’escalation militare a Gaza, che polarizza l’opinione pubblica tra chi sostiene la linea dura del governo e chi, invece, teme che l’intensificazione delle ostilità porti solo a ulteriori violenze e insicurezza. In molti quartieri di Tel Aviv e Gerusalemme si registrano assemblee spontanee, in cui cittadini, attivisti e membri della società civile discutono apertamente delle conseguenze dell’operazione militare e delle politiche governative.
Parallelamente alle proteste nelle grandi città, anche nelle aree periferiche e nelle comunità miste arabo-ebraiche si sono svolte manifestazioni contro la guerra e contro le decisioni del governo. Alcuni leader della minoranza araba in Israele hanno criticato duramente l’operazione a Gaza, definendola una “campagna di distruzione sistematica” e chiedendo un immediato cessate il fuoco. Anche alcune voci autorevoli della diaspora ebraica, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, si sono espresse contro la gestione della crisi da parte di Netanyahu, sottolineando la necessità di soluzioni diplomatiche anziché militari.
Le proteste rappresentano un punto di rottura significativo nella politica israeliana, evidenziando una crescente polarizzazione tra sostenitori e oppositori dell’attuale governo. Nonostante le critiche, Netanyahu appare determinato a mantenere la linea dura, contando sul sostegno di una parte significativa dell’elettorato conservatore e sulla fiducia della sua base politica, rinvigorita dalla presenza di Ben-Gvir. Tuttavia, la persistenza delle manifestazioni e l’eventuale ampliamento del fronte di opposizione potrebbero mettere ulteriormente alla prova la tenuta del governo, già scosso dalle turbolenze politiche e dalla crescente instabilità sociale.
L’ombra della collaborazione USA-Israele
La crisi a Gaza non si consuma solo tra le polveri e il dolore della Striscia, ma si intreccia anche con dinamiche geopolitiche che coinvolgono attori internazionali di primo piano, tra cui gli Stati Uniti. La storica alleanza tra Washington e Tel Aviv continua a giocare un ruolo cruciale nell’evoluzione del conflitto, con un sostegno politico e militare che non è mai venuto meno, nonostante i cambiamenti alla guida della Casa Bianca.
Durante l’amministrazione Trump, il rapporto tra Israele e Stati Uniti ha raggiunto livelli di complicità senza precedenti. Uno dei simboli più evidenti di questa sinergia è stato il trasferimento dell’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo di fatto la città come capitale di Israele, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti e acceso nuove tensioni nella regione. La retorica di Trump, fortemente orientata alla difesa degli alleati israeliani, ha contribuito a consolidare un’alleanza basata non solo su interessi strategici ma anche su un’affinità ideologica tra Trump e il primo ministro Netanyahu.
Durante il periodo di Trump, la Casa Bianca ha supportato senza riserve le operazioni militari israeliane, giustificando ogni azione come necessaria per la sicurezza dello Stato ebraico. La portavoce dell’amministrazione, Karoline Leavitt, aveva affermato chiaramente che qualsiasi minaccia contro Israele o contro gli Stati Uniti avrebbe comportato gravi conseguenze. Questo atteggiamento ha consolidato un asse politico e militare che ha fornito a Israele il margine necessario per espandere la propria presenza militare e portare avanti azioni aggressive contro i gruppi armati palestinesi.
Con l’elezione di Joe Biden alla presidenza, molti analisti speravano in un cambio di approccio più equilibrato. Tuttavia, l’atteggiamento della nuova amministrazione si è rivelato altrettanto solido nel sostegno a Israele, seppur con una retorica apparentemente più moderata. Biden ha formalmente invitato alla moderazione e al dialogo, ma nei fatti ha continuato a garantire il sostegno militare e finanziario necessario a mantenere l’apparato bellico israeliano in piena efficienza. La continuità di politiche tra le due amministrazioni riflette la persistenza di un orientamento strategico consolidato da decenni, dove la sicurezza di Israele è considerata una priorità assoluta e imprescindibile.
Oltre al sostegno militare, l’amministrazione Biden ha adottato una politica di rigido controllo interno, soprattutto nei confronti delle voci critiche all’interno degli Stati Uniti. Ogni critica alla politica israeliana è stata spesso etichettata come antisemitismo, creando un clima di intimidazione tra intellettuali, studenti e attivisti. Un esempio emblematico è il caso di Mahmoud Khalil, uno studente palestinese arrestato in Louisiana e detenuto in isolamento dopo aver espresso critiche alla gestione del conflitto da parte di Israele. Questo episodio ha suscitato un dibattito acceso sulla libertà di espressione nelle università americane, soprattutto dopo le minacce dell’amministrazione Trump di tagliare i fondi federali alla Columbia University se non avesse adottato una politica di tolleranza zero verso il dissenso.
La questione della repressione del dissenso non è nuova ma ha raggiunto nuovi picchi sotto entrambe le amministrazioni, mostrando come il supporto a Israele si intrecci con una politica interna di limitazione delle libertà civili. Biden, pur prendendo le distanze dalle dichiarazioni più estreme di Trump, non ha revocato molte delle misure repressive introdotte durante la presidenza precedente. Questo ha lasciato molti attivisti per i diritti umani disillusi e preoccupati per il futuro della democrazia americana e per il progressivo soffocamento delle voci critiche.
La posizione degli Stati Uniti ha quindi un duplice effetto: da un lato, garantisce a Israele il supporto politico e logistico necessario per mantenere l’offensiva militare; dall’altro, crea un clima interno di censura e repressione nei confronti di chi si oppone alla linea ufficiale. Questo assetto riflette una visione geopolitica che privilegia la stabilità strategica e l’alleanza militare a scapito dei diritti umani e della trasparenza democratica.
Il supporto statunitense non si limita alla fornitura di armamenti o alla copertura diplomatica presso le istituzioni internazionali. Include anche il consolidamento di una narrativa che giustifica l’uso della forza come risposta a qualsiasi percepita minaccia alla sicurezza nazionale. Tale approccio ha consentito a Netanyahu di agire con ampio margine e senza timori di gravi ripercussioni da parte della comunità internazionale, rendendo la cooperazione con Washington un pilastro insostituibile della politica estera israeliana.
Allo stesso tempo, la forte vicinanza tra i due governi ha posto gli Stati Uniti sotto la lente d’ingrandimento della critica globale. Molti alleati europei, pur sostenendo Israele in linea di principio, hanno espresso perplessità per la linea intransigente di Washington, chiedendo una maggiore pressione diplomatica per un cessate il fuoco immediato. Tuttavia, la Casa Bianca si è limitata a dichiarazioni di circostanza, continuando a ribadire il diritto di Israele alla difesa e ignorando le crescenti denunce di violazioni dei diritti umani.
La collaborazione tra Stati Uniti e Israele, dunque, non è solo una questione di affinità politica, ma rappresenta una precisa scelta strategica in un contesto mediorientale sempre più instabile. Mentre a Gaza continuano i bombardamenti e il bilancio delle vittime aumenta, l’ombra della complicità americana pesa sulla capacità della comunità internazionale di rispondere in modo efficace alla crisi umanitaria in corso.