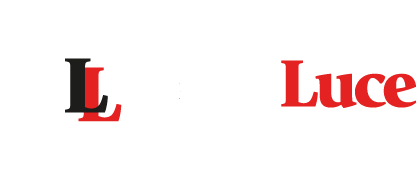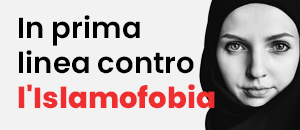“Il nibbio” è un recente lavoro cinematografico sulla vicenda di Nicola Calipari, agente del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) ucciso da fuoco amico (americano) nel contesto della liberazione di Giuliana Sgrena, giornalista de Il manifesto fatta ostaggio dell’Insurrezione sunnita irachena nel 2005.
Anche se la criminale arbitrarietà dell’intervento americano in Iraq (criminale, si badi, a causa della sua cattiva coscienza, prima ancora che per la tortura e il massacro dal cielo inflitti a un nemico inerme) è oramai di pubblico dominio in Occidente1, non fa male ricordare che la strategia del divide et impera a estromettere i sunniti dalla ricostruzione del Paese si contorse, immediatamente dopo gli eventi trattati nel film, nella spirale della guerra civile la cui letalità avrebbe presto sorpassato il centinaio di migliaio di morti2 (biennio 2006-2007 il più cruento).
Su Nicola Calipari “Il nibbio”, ha scritto, con rispetto e sagacia, Massimo Fini: «Ho il massimo rispetto per quest’uomo e il suo tragico destino. Ma trovo significativo e simbolico che l’unico autentico eroe che l’Italia abbia saputo esprimere in sessant’anni di dopoguerra sia una spia3». Frase in alcun modo volta a denigrare l’uomo Calipari, il quale sacrificò la propria vita per quella della giornalista interponendosi tra questa e i proiettili americani, quanto piuttosto a ridimensionare il sistema politico, mediatico e in ultima analisi sociale nel quale Calipari si muoveva e che forzatamente rappresentava.
I problemi sia di natura artistica che storico-concettuale del film (di cui a breve), hanno, a parere di chi scrive, molto a che vedere con la coscienza non risolta dell’opinione pubblica occidentale (in questo caso italiana) nei confronti delle guerre scatenate a partire dagli anni novanta dall’Occidente al resto del mondo. Le motivazioni di tale coscienza non-riconciliata4 possono essere ricondotte con buona approssimazione a due elementi, in buona parte sovrapponibili. Il primo è un fatto eminentemente storico, recentemente sintetizzato da Alessandro Orsini in un articolo sulla società post-moderna. Secondo il professor Orsini, la società post-moderna si distingue per un marcato individualismo, un diffuso edonismo, una incertezza valoriale e relazionale più o meno costante che comporta un altrettanto pervasivo relativismo. La prima grande nevrosi 5 di cui soffre l’opinione pubblica occidentale, ove la società post-moderna6 è pienamente realizzata, è dunque quella di sapersi un sistema relativista e post-valoriale, e allo stesso tempo di esportare il proprio modello (la liberal-democrazia) in maniera profondamente religiosa e dogmatica, cioè violenta. Questa è poi la ragione per cui tutte le guerre “di liberazione” scatenate dall’Occidente sono state vissute da chi le ha subite per quello che in effetti erano, ovvero invasioni7.
Il secondo elemento disgregante è che, come ha felicemente sintetizzato Edward Luttwak, le guerre scatenate dalle società post-moderne sono, obbligatoriamente, post-eroiche. La post-eroicità della guerra occidentale, riprendendo nuovamente Fini, si deve sostanzialmente alla vertiginosa sproporzione tra il potenziale tecnico dell’Occidente (alla base anche del suo modello sociale, quello appunto, post-moderno) anche in termini bellici, che ha introdotto concetti strategici prima sconosciuti quali la guerra a zero perdite e quella boots on the ground8. Mentre la prima espressione rimanda alla guerra pilotata dall’alto e, più recentemente, da remoto attraverso l’utilizzo di droni, che permettono operazioni ingegneristiche ove il combattimento quale scontro di volontà e misura della reciproca forza è scomparso, la seconda è ancora più eloquente, perché sancisce l’eccezionalità dello scontro diretto ove il soldato, minacciato fisicamente dal nemico, può perdere la vita (nelle società Altre questa eventualità rappresenta ancora la totalità e l’essenza del fenomeno guerra). Più semplicemente, raffrontando il numero di caduti tra le forze di occupazione e la resistenza autoctona nei due conflitti più impegnativi per gli Occidentali dagli anni ’90 a oggi9, ovvero Afghanistan e Iraq, si ravvisa come il rapporto dei morti tra le parti in causa è di uno a venti. Poiché uno scarto simile non è causato né da formidabile coraggio né da eccezionali doti belliche del soldato occidentale, ma da un divario eminentemente tecnico10, la coscienza pubblica incontra grande difficoltà a chiarire (innanzitutto a se stessa) l’assunto valoriale che muove queste guerre nonché la mancanza di dignità con cui vengono combattute.
Questi nodi non risolti influenzano, e non poco, il funzionamento del film, che non può assurgere a dramma epico proprio perché il supporto italiano all’invasione dell’Iraq non ebbe alcuna dimensione epica. “Il nibbio” è dunque sostanzialmente deludente, se si mette da parte il dovuto tributo alla figura di Calipari, che sacrificò la propria vita per quella di una connazionale e il cui sacrificio non ha trovato responsabili11.
Da un punto di vista strettamente rappresentativo, esso manca di pathos. Gli interpreti, Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco, mettono in scena (probabilmente facendo un torto alla verità storica) due figure piuttosto scialbe. Il Calipari del film è un uomo con alto senso del dovere, deontologia e vita privata ineccepibile. La sua politica di pagamento dei riscatti, in contraddizione con l’approccio militarista e senza compromessi di Washington che vedeva in essa un incentivo al moltiplicarsi dei rapimenti, la sua predilezione per la trattativa, che ingelosiva non poco alcuni colleghi a causa del protagonismo di “Nibbio” 12, e infine l’amicizia stretta con l’allora direttore de Il Manifesto non sfociano in tentennamenti di coscienza rispetto alla questione dell’occupazione italo-americana. Ciò è tanto più sorprendente vista la sensibilità pacifista e anti-americana che animava l’opinione pubblica mobilitatasi per Sgrena, che la sua liberazione fosse dunque politicamente connotata, e che le scelte di Calipari per liberarla avessero incluso un ingente trasferimento di denaro a un esponente dell’Insurrezione sunnita.
La Giuliana Sgrena di Sonia Bergamasco non è, a sua volta, né vittima né carnefice: ambigua figura di pacifista in una guerra dal tasso di violenza estremo da entrambe le parti (sempre, si ricordi, con una ratio di perdite occidentali-irachene intorno a uno a venti), la Sgrena sembra, in una scena a mio avviso rivelatoria13, indifferente alla dimensione culturale del conflitto. Il che è tanto più grave svolgendo quest’ultima un lavoro eminentemente intellettuale.
La trama si dipana insomma come quella di un film d’azione, che non necessita, per sua natura, di grosse conoscenze intorno a una questione, quella del conflitto iracheno, tuttora molto vicina a noi e di fatto non storicizzata (non risolta, per tornare alla discussione di cui sopra). Anche da questo punto di vista però, senza il ritmo sincopato della colonna sonora e le sigarette che accompagnano ogni conversazione tra i protagonisti della trattativa, oltre a qualche inquadratura suggestiva (bombardieri che incrociano sul deserto, campi base, berline laccate di nero tra un Ministero romano e l’altro) il film starebbe difficilmente in piedi. Di fatto, esso finisce per banalizzare una tragedia familiare, quella di Calipari, nel contesto di un’immensa tragedia sociale, chiamata Iraq.
Perché tragedia solo familiare? Perché lo spettatore ha purtroppo gioco facile nel riconoscere nel sistema nel quale Calipari si muove la pochezza, sia morale che intellettuale, della classe dirigente nostrana. Oltre alla confusa retorica della piazza pacifista coordinata da Il manifesto 14, allo scontro di egoismi e ai pericolosi sgambetti da parte dei colleghi all’interno del SISMI, il film mostra come, mentre Calipari e Sgrena ancora non si trovavano all’aeroporto di Baghdad (sarebbero stati colpiti dal fuoco americano a pochi chilometri dall’arrivo) l’allora presidente del Consiglio già annunciava, trionfalmente e tronfiamente, il successo della trattativa e il merito del suo governo; commiserava il compagno di Sgrena per “il ritorno della moglie,”; e, molto presto, avrebbe fatto pressione per l’insabbiamento dell’inchiesta sulla morte.
Un grande non detto che attraversa il film è il subdolo rapporto di potere instauratosi in Iraq tra americani e italiani: il mai esplicitato eppur coercitivo controllo della strategia politica e militare è tuttavia palesato dal fatto che «[nello svolgimento dell’inchiesta] la magistratura ha incontrato difficoltà ed impedimenti nello svolgimento della funzione inquirente a causa del particolare status della zona in cui si sono svolti i fatti, che risultava essere territorio iracheno sottoposto a controllo militare e sovranità di fatto statunitense; negato dagli Stati Uniti il permesso di far analizzare a tecnici della polizia scientifica italiana il veicolo su cui viaggiava Calipari, i giudici hanno dovuto attendere la conclusione dei rilievi statunitensi per poter avere a disposizione il mezzo. Il diniego, motivato con ragioni militari, ha di fatto provocato lo scadimento del valore probatorio del reperto, rendendone l’esame sostanzialmente inattendibile»15.
Purtroppo, anziché capitalizzare sull’ipocrisia della retorica dell’alleanza, che il caso Calipari manifesta essere in realtà una sudditanza, e che potrebbe essere, insieme a una revisione del racconto sull’invasione dell’Iraq, il tema portante del film, esso preferisce l’azione alla sana, doverosa e ormai matura riflessione sull’intera vicenda.
1 Il che non impedisce il reiterarsi del sopruso da parte degli stessi protagonisti: questa settimana il computo
dei morti nella Striscia di Gaza tocca i cinquantamila.
2 È interessante, direbbe Massimo Fini, dal quale attingo ancora a seguire, come il dato numerico venga
reinterpretato nella narrativa nostrana sulla “Guerra al terrore”. Il rapporto della letalità del conflitto afghano
tra americani e taliban fu di circa un caduto americano per ogni venti perdite talebane. La strage di Nassiriya
(Iraq) ove persero la vita diciannove tra soldati e personale dell’esercito italiano, viene giustamente ricordata
con una stele presso il Monumento ai Caduti a Milano. E tuttavia è assai raro avere occasione di discutere il
dato, forse più significativo, dei cinquemila decessi provocati dalla Coalition of the willing quale cerimonia
di apertura della liberazione dell’Iraq al termine della sua prima settimana di operazioni. Anche se i numeri,
si dice, sono di per sé privi di significato, le nude cifre qui abbozzate meritano forse un accenno di
considerazione.
3 Fini, Il ribelle: dalla A alla Z, cit. p. 789.
4 Mi riferisco qui ovviamente all’opinione di alcuni cittadini comuni e non certo a quella della classe politica
nostrana, sempre saldamente a fianco degli Stati Uniti nell’ora fatale della guerra al Terrore, alle Autocrazie,
al Male, atteggiamento, come noto, trasversale all’intero spettro politico. All’invasione irachena
parteciparono solo, oltre ai britannici, gli spagnoli e i polacchi, questi ultimi con contingenti peraltro più
ridotti del nostro.
5 Il Fatto Quotidiano, 11/03/2025, p. 11.
6 La nevrosi è, per l’appunto il frutto della coscienza non-riconciliata.
7 Evitando riferimenti espliciti, la cronaca recente e meno recente pullula di giornalisti così detti embedded,
reporter di guerra e cooperatori i quali, sottovalutando il significato tutto politico del loro ruolo e della loro
presenza, diventano facilmente causa di pesanti scontri diplomatici tra le parti in causa. Fu il caso, a mio
avviso, anche di Giuliana Sgrena, giunta in Iraq a difendere un non meglio specificato pacifismo ma
scarsamente sensibile al contesto e alla cultura locali. Il film illustra molto bene la questione in una scena
nella quale il mujahid che la tiene prigioniera le chiede la ragione per cui non è credente e non prega.
Significativamente, la Sgrena (Sonia Bergamasco) non sa rispondere.
8 Per una trattazione estensiva di questo tema si rimanda al magistrale Fini, Massimo. Il Mullah
Omar. Venezia: Marsilio, 2019.
9 Oltre all’impietoso saldo di morte nella Striscia di Gaza, ove per ogni vittima israeliana del 7 ottobre 2023
si registrano quaranta decessi tra i palestinesi, l’altro caso macroscopico che coinvolge l’Occidente è quello
ucraino. Ma in Ucraina, sia detto senza voler infierire, i morti aumentano in maniera proporzionale su
entrambi i fronti perché a combattere il Male russo sono gli ucraini, che non sono né americani né inglesi né
italiani.
10 Un’immagine iconica del romanticismo finiano è quella del capo talebano Omar che fugge da caccia F35
ed elicotteri Black Hawk in bicicletta, protetto dal solo fucile kalashnikov.
11 Il materiale di approfondimento sulla vicenda politica e legale seguita alla morte di Calipari è relativamente
scarso, ma riflette assai fedelmente i rapporti di forza passati e presenti tra il nostro Paese e Washington,
peraltro accentuati dal vassallaggio del governo Berlusconi nei confronti dell’amministrazione Bush in quel
periodo. La mancata trattazione della sostanziale connivenza di parte del potere italiano nei confronti di
quello americano nell’oscurare la vicenda è un evidente e pesante vulnus del film.
12 E infatti una delle inchieste svolte ha portato nella direzione del deliberato attentato a Calipari-Sgrena da
parte degli americani, con la complicità di alti livelli dell’esercito italiano.
13- E infatti una delle inchieste svolte ha portato nella direzione del deliberato attentato a Calipari-Sgrena da parte degli americani, con la complicità di alti livelli dell’esercito italiano.
14-La quale ricorda molto da vicino la recente Piazza per l’Europa organizzata da Michele Serra. Nessuno chiarì se il richiamo alla pace fosse dovuto alla cattura di un’italiana (hanno catturato uno dei nostri, quindi ci arrendiamo) o a un, forse più dignitoso, interrogativo morale sulla liceità del massacro di civili iracheni con armi ad alta tecnologia. Di fatto, il governo perseguì l’una (la liberazione dell’ostaggio) e l’altra cosa (il sostegno incondizionato agli Stati Uniti). Tale confusione è sintomatica della post-modernità a cui si faceva cenno prima.
15-Cit. da Wikipedia, “Nicola Calipari”, ultimo accesso il 25/03/2025.