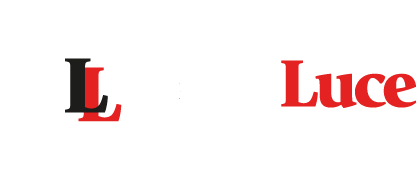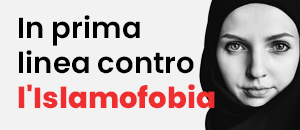“A cosa serve la manifestazione del 12 aprile?” Me lo ha chiesto una giovane madre di famiglia musulmana. “Che cosa si pensa di ottenere? Ci sono state manifestazioni enormi, non tanto in Italia quanto altrove, nel Regno Unito, in America, ed è forse cambiato qualcosa?” E’ una domanda importante. Perché segnala due rischi: uno riguarda le coscienze, l’altro riguarda le conseguenze. Il primo rischio è quello dell’autocompiacimento o dello scoraggiamento che sono due facce della stessa medaglia. Se il 12 aprile ci sarà, Dio permettendo, una grande manifestazione tutti noi partecipanti rischieremo di sentirci soddisfatti e autorizzati a riposarci un poco. Se la risposta all’appello per il 12 aprile sarà deludente ci sentiremo scoraggiati e giustificati nella nostra inazione. Il secondo rischio è quello dell’irrilevanza, il tarlo che da tempo rode silenziosamente l’albero democratico sui cui rami siamo confortevolmente seduti. Esso può farci dimenticare il valore della libertà d’espressione, percepita come libertà di chiacchierare senza essere ascoltati, e di sfogarsi in rituali collettivi che lasciano il tempo che trovano.
Per rispondere alla domanda della giovane madre facciamo un salto indietro e chiediamoci: le grandi manifestazioni che hanno seguito il 7 ottobre in Italia e nel mondo hanno cambiato qualcosa? La risposta è sì, hanno cambiato moltissimo. A Milano, subito dopo il 7 ottobre, ce ne fu una al contempo enorme e variegata. Aveva due caratteristiche che da tempo non si vedevano: era estremamente composita per genere, generazioni, condizioni sociali e appartenenze culturali e vi spiccava una folta presenza di musulmani. Esprimeva a tutti gli effetti il senso di una svolta storica avvenuta il 7 ottobre 2023. Tra le vecchie generazioni serpeggiava il ricordo dell’offensiva del Tet in Vietnam, nel 1968, anch’essa accompagnata da mobilitazioni massicce nelle università, anch’essa risoltasi alla fine in una sconfitta della resistenza che tuttavia era preludio alla sua vittoria finale. Tra le generazioni intermedie circolavano invece ricordi di manifestazioni pro Palestina sempre più sparute come quella di Roma cui venne permesso di arrivare fin davanti all’ambasciata degli Usa in Via Veneto mentre qualcuno commentava sconsolato: “Se è così meglio non farle, le manifestazioni! Servono solo a far vedere agli americani quanto siamo pochi. Dobbiamo inventarci qualcos’altro.” Quel qualcos’altro erano le “spaghettate per la Palestina” – come ebbe a definire con lucida ironia un italiano musulmano – quegli eventi tra il militante ed il folcloristico che si tenevano in occasioni di feste palestinesi, spesso sotto l’egida dell’Anp, in un tripudio di canti tradizionali, bandiere, kefiah e lunghe tavolate.
La Palestina aveva smesso da tempo di essere un problema per i paesi occidentali, per i suoi vicini mediorientali e per gli stessi sionisti, come sta a dimostrare lo stato di avanzamento degli “accordi di Abramo” alla vigilia del 7 ottobre. Quella data ha ribaltato bruscamente lo scenario: la questione palestinese è tornata clamorosamente in prima linea, gli accordi di Abramo si sono bloccati. Non solo: abbiamo assistito ad un rovesciamento dell’opinione pubblica in Occidente e nel mondo, così repentino che dovrà essere oggetto di studio per ricercatori di oggi e domani. Ad esso hanno certamente contribuito le manifestazioni a ridosso del 7 ottobre 2023 e quelle che si sono susseguite per oltre un anno.
Si può stimare che, un anno dopo, le manifestazioni in concomitanza del 7 ottobre 2024, inizialmente vietate, per le quali è stato necessario strappare l’autorizzazione anche grazie ad intelligenti azioni politiche, abbiano rappresentato il picco di questa fase prima fase di solidarietà attiva nei confronti della resistenza palestinese. Da un lato il 7 ottobre 2024 celebrava l’incredibile portata di una resistenza ancora in piedi dopo un anno, allorché l’esercito israeliano contava di liquidarla in poche settimane, gli israeliani erano convinti che la loro vita sarebbe ripresa come niente fosse, riservisti e volontari erano affluiti entusiasti, convinti di andare incontro, come in passato, ad una bella avventura con molta gloria e pochi rischi. Dall’altro si respirava in sottofondo un sentimento di impasse che chiamava ad una svolta: se un anno di resistenza aveva smentito calcoli più realistici, una resistenza prolungata indefinitamente era del tutto irrealistica. Questa svolta veniva individuata nell’accordo sul cessate il fuoco. Mentre i responsabili politici della resistenza negoziavano strenuamente i termini di un accordo che desse una qualche garanzia, mentre la popolazione di Gaza sopportava pazientemente bombardamenti ancora più furiosi in prossimità dell’accordo, noi qui ci siamo messi ad aspettare, sperare e scambiarci news sui social (e prima o poi bisognerà interrogarsi sulle finalità di questi scambi frenetici di notizie in tempo reale).
L’accordo raggiunto a fine gennaio era un buon accordo ma estremamente precario per un semplice motivo: il governo Netanyahu affermava esplicitamente di essere pronto a violarlo in qualunque momento. Le potenze mediatrici fingevano di non sentire – e questo era probabilmente necessario nel gioco dei tavoli diplomatici – noi invece, pubblica opinione libera da responsabilità decisionali, abbiamo preferito ignorare e festeggiare. Vi era un’unica garanzia materiale all’accordo: la riapertura del corridoio di Netzarim e il contro-esodo di dimensioni bibliche della popolazione sfollata verso il nord. Esso era il chiaro segnale della determinazione della maggioranza dei Palestinesi di restare attaccati alla propria terra e costituiva una massa critica di “scudi umani volontari” che coi loro corpi di civili, di famiglie, di donne e bambini difendevano la terra che era stata loro restituita a seguito di un accordo garantito da potenze mediatrici internazionali. Perché in quei giorni sussisteva ancora un barlume di fiducia nel diritto internazionale, nelle buone consuetudini delle relazioni internazionali, nel principio che pacta sunt servanda.
Quel residuo baluardo di un mondo dove si credeva vi fossero alternative alla ragione del più forte è andato definitivamente in frantumi tre settimane fa (il 18 marzo 2025), quando l’accordo è stato violato unilateralmente da Israele – senza nemmeno venire prima denunciato secondo le buone consuetudini d’antan – con una ripresa di bombardamenti a tappeto sugli sfollati rientrati nelle loro terre, che in un solo giorno ha fatto quattrocento vittime, mentre il governo sionista annunciava contemporaneamente il blocco totale dell’ingresso di aiuti che erano parte dell’accordo ma anche obbligo secondo il diritto umanitario. Questa volta i sionisti non si sono nemmeno presi la briga di far finta di ricorrere ad un qualunque criterio di legalità internazionale. La cosiddetta “comunità internazionale” (l’Occidente) si è limitata come al solito ad esprimere blandamente la propria riprovazione; i mediatori internazionali garanti dell’accordo si sono volatilizzati; la stampa nostrana ci ha messo settimane per chiamare le cose con il loro nome spolverando come al solito una panoplia di eufemismi riassumibili in quello ineffabile di Avvenire che parla di “capriccioso rifiuto di Hamas” di accettare “l’estensione della fase uno dell’accordo” (ossia la sua nullificazione). Tutto questo era largamente prevedibile ma ci ha colto – per quel che ci compete, a noi cittadini di un paese (ancora) libero, impreparati.
Certo, la sera stessa della ripresa dei bombardamenti su Gaza la comunità palestinese in Italia ha convocato immediati presidi di emergenza in tutte le città. A Milano, in piazza dei Mercanti, si sono radunati alcune centinaia di manifestanti, esponenti delle principali sigle palestinesi, dei movimenti della sinistra antagonista, delle vecchie generazioni, delle correnti anticapitaliste di ispirazione marxista. E già si notava un ritorno ai vecchi tempi, con la presenza assai più numerosa della sinistra antagonista rispetto alla componente musulmana. Subito dopo, diversi gruppi e sigle hanno promosso una manifestazione nazionale di solidarietà con il popolo palestinese, a Milano, il 12 aprile: cioè un mese dopo la rottura della tregua, a dimostrazione di quanto la capacità di mobilitazione dei movimenti sociali si sia indebolita, erosa anche dal dilagare delle reti sociali.
Alla manifestazione, con un tempismo inedito, aderisce immediatamente l’Ucoii che è pur sempre la principale espressione rappresentativa e organizzativa dei musulmani in Italia. Fatto ancora più inedito, il prudente e diplomatico presidente dell’Ucoii, Yassin Lafram, invita gli imam e i responsabili dei centri islamici a incoraggiare i fedeli a partecipare alla manifestazione, a ricordarla durante la khutba, a organizzare autobus ad hoc. L’Ucoii, con linguaggio inabitualmente duro, parla di “genocidio”, afferma che “il silenzio è complicità” e articola quattro obiettivi: “la fine immediata dell’occupazione illegale dei territori palestinesi e del regime di apartheid, il riconoscimento del diritto del popolo palestinese a uno Stato indipendente e sovrano, il cessate il fuoco immediato e duraturo e la fine della repressione contro chi denuncia questi crimini”. Già un anno fa però, in un comunicato del 30 maggio 2024, lo stesso Lafram, scrivendo che “è il momento dei fatti, delle azioni concrete e non dello sterile disappunto espresso con timide frasi di circostanza da parte di tanti governi della nostra Europa” individuava altre azioni concrete: “sanzioni, stop alla vendita di armi, l’invio di una forza internazionale di interposizione a salvaguardia della popolazione civile di Gaza”, invitando il governo italiano a “mettere in campo azioni diplomatiche” e a fare “pressioni su Israele affinché cessi il fuoco contro la popolazione di Gaza”.
Cosa è stato fatto di tutto questo? Cosa si è ottenuto? Ai dubbi della giovane madre musulmana occorre rispondere che la manifestazione del 12 aprile è stata una necessità politica ed un dovere etico ma che non otterremo nulla se la consideriamo un punto di arrivo (autocompiacimento) dopo il quale torneremo a rifugiarci nello spazio virtuale (irrilevanza), anziché prenderla come un punto di partenza.
Scendere in piazza massicciamente il 12 aprile ha risposto in primo luogo ad un bisogno urgentissimo: riportare Gaza e la Palestina al centro dell’attenzione. Massacri, distruzioni, blocco degli aiuti hanno ripreso nella distrazione generale dell’Italia e dell’Europa al momento in affanno per la questione dei dazi americani. Silenzio ancora maggiore è quello sui crimini quotidiani in Cisgiordania di cui peraltro la nostra stampa parla: in poche righe di pagine interne, cosicché o non attirano l’attenzione o peggio danno l’impressione che non si tratti di cose gravi. E la ummah, stanca e scoraggiata, già torna a ripiegarsi su sé stessa nel suo mondo di chat e di video, condannandosi all’irrilevanza di chi grida senza riuscire a farsi ascoltare, o parla così sommessamente che si sospetta non voglia farsi sentire. La manifestazione del 12 aprile ha avuto dunque lo scopo di rimaterializzare nello spazio fisico le voci di protesta perché ciò che avviene nello spazio virtuale rimane del tutto irrilevante se non si rimaterializza nello spazio fisico.
In secondo luogo, occorre capire che lo spazio fisico non può essere solo quello episodico di una manifestazione o di un presidio, nemmeno se queste si ripetono regolarmente, perché il loro accumulo di energia gradualmente si esaurisce. Occorrono spazi più stabili, la cui frequentazione diventi in qualche sorta un habitus, dove si produce cultura e si articola la domanda politica. La comunità islamica, in una metropoli come Milano, non ha una libreria (l’unica che avevamo ha chiuso di recente), un circolo di lettura, un caffè letterario, un cineclub, un centro sociale. Il 7 ottobre ha dato visibilità alla ricca produzione letteraria, cinematografica, scientifica palestinese (ci avevano convinti che gli unici a produrre letteratura, scienza e arte fossero gli ebrei) ma questa visibilità scomparirà appena cesserà di servire ad interessi commerciali e politici che non sono i suoi. A scuola ci insegnavano che Le mie prigioni – il libro del patriota risorgimentale Silvio Pellico – hanno provocato all’occupante austriaco “più danni di una battaglia perduta” ma noi abbiamo difficoltà a fare una presentazione del romanzo autobiografico di Yahya Sinwar, Le spine e il garofano.
In terzo luogo, occorre capire che nulla si ottiene senza l’articolazione di una domanda politica sostenuta da strumenti specifici e capacità di premiare o sanzionare. “Articolazione di una domanda politica” non significa né partecipare ogni tanto o anche ogni sabato (pur rivolgendo un pensiero grato a chi lo fa) ad una manifestazione e nemmeno passare il tempo a postare video sui social, distribuire like, e dire ogni tanto la nostra su qualcosa di cui non siamo necessariamente competenti. Significa invece disporre di luoghi di dibattito politico quotidiano in cui si costruiscono alleanze e si elaborano pazientemente posizioni condivise che abbiano sufficiente autorevolezza da obbligare chi detiene il potere a tenerne conto. In passato ci sono stati alcuni tentativi generosi in tal senso e sono falliti: occorre analizzarne i limiti e gli errori, non smettere di provarci. Altrimenti ci svegliamo quando c’è un 7 ottobre, una intifada, una rivoluzione e ci riaddormentiamo dopo la solita, inevitabile, sconfitta. E’ indispensabile che la ummah superi la sua ritrosia – se non addirittura la sua repulsione – per il fatto politico, frutto di secoli di storia, di regimi autoritari, di fragilità migratoria e di povertà culturale. E’ indispensabile che si riappropri almeno dei rudimenti del pensiero politico islamico, quello dei secoli passati e quello contemporaneo, senza lasciarne il monopolio agli orientalisti o tutt’al più agli islamologi amici. Se non facciamo questo continueremo a piangere sulla nostra impotenza ed a vergognarci dei nostri tradimenti. Eppure non siamo affatto impotenti e questo ci rende ancora più colpevoli.
I musulmani sono il 5% circa della popolazione italiana e più della metà di essi ha la cittadinanza italiana: non rischiano espulsioni, perdita di permessi di soggiorno, rifiuto di ricongiungimenti familiari. Hanno il diritto di voto di cui sembra non sappiano bene cosa fare. Allora si potrebbe prendere in considerazione una cosa molto semplice: i musulmani, con idee, posizioni e simpatie politiche diverse, si uniscono nel dichiarare che non voteranno nessuna lista, partito o candidato che ha sostenuto o sostiene Israele e incanaleranno di preferenza il loro suffragio verso partiti, liste o candidati che hanno daato un supporto concreto alla causa palestinese.
Accanto al diritto di voto c’è la rappresentanza. I musulmani oggi sono presenti all’interno di assemblee politiche a tutti i livelli, ma soprattutto ai livelli di prossimità: circoscrizioni, municipi, piccoli e grandi comuni. Quanti sono non ci è dato sapere, altro segno della nostra noncuranza. Si potrebbe creare un coordinamento degli eletti musulmani per ottenere cose molto precise come l’invio di aiuti umanitari, l’accesso di delegazioni alle zone di guerra, l’ingresso di giornalisti, ecc.Sono cose che i Cattolici lo fanno da anni – basti guardare alla comunità di S. Egidio.
Abbiamo sempre più giovani che frequentano l’università e si organizzano in associazioni: potrebbero incominciare a far sentire la loro voce nel discorso politico. Sarebbe una voce nuova, fresca, capace di portare contenuti diversi da quelli spesso logori delle correnti politiche tradizionali. Le università oggigiorno offrono spesso spazi, anche stabili: perché non usarli per offrire a tutti gli studenti, al mondo accademico e ad un pubblico più vasto quei contenuti che i giovani musulmani possono portare, in modo stabile e non solo sull’onda di proteste contingenti? La stabilità deve essere un tratto indispensabile di questa pratica: da quanti anni si parla di Palestina nelle nostre università senza che regolarmente la Palestina venga poi dimenticata mentre la narrativa sionista è andata crescendo ed espandendosi a dismisura?
Il numero crescente di professionisti musulmani, perlopiù giovani, presenti in molti settori, si è dato recentemente una struttura associativa stabile (Promus), un assetto organizzativo e comunicativo efficace, una presenza nello spazio pubblico con iniziative culturali anche di interesse generale e sta incominciando ad misurarsi sulle modalità di intervento nel campo delle politiche pubbliche. Tra i professionisti vi sono quelli le cui competenze, e la cui capacità di far rete, possono avere un peso importante nelle azioni concrete per la Palestina: medici, avvocati, giornalisti. Hanno aderito alla manifestazione del 12 aprile: cosa intendono fare il giorno dopo?
Sul piano dei media non abbiamo molto, è vero – a parte questo giornale e qualche timido approccio ai canali televisivi – e ci lamentiamo ogni giorno, a ragione, dell’ostilità dei media mainstream che nel caso della Palestina passerà alla storia come la vergogna della categoria dei giornalisti. E’ di questi giorni però la bella notizia dell’assegnazione del Premio Tiziano Terzani alla memoria dei giornalisti palestinesi uccisi a Gaza. Potrebbe essere un punto di partenza per organizzare una partnership in forme più stabili tra giornalisti e media in Italia e in Palestina, magari con qualche coinvolgimento dell’accademia. E sempre nelle università si possono trovare docenti disposti a dare un mano a chi volesse cimentarsi nel campo delle radio libere dal glorioso passato.
Sul piano dell’editoria, libri sulla Palestina si pubblicano e si traducono ma potremmo fare più sforzi per “fare sistema”, cioè mettere insieme e rendere visibile tutto ciò che esiste. Anche qui la presenza nello spazio fisico è indispensabile e non dovrebbe costare molto in termini di denaro ospitare una mostra sulla letteratura palestinese, con qualche presentazione e discussione, nelle numerosissime e ottime biblioteche di quartiere di cui Milano e tante altre città dispongono. La bellissima Biblioteca Amilcar Cabral di Bologna ospita da tempo un gruppo di lettura sulla letteratura israeliana contemporanea. Cosa aspettiamo a farne almeno uno sulla letteratura palestinese a Milano?
Ho lasciato da ultimo, appositamente, la risorsa delle moschee. E’ vero ai musulmani vengono create difficoltà di ogni sorta. E’ vero, ci troviamo perlopiù alle prese con politiche ostili alla costruzione di moschee. E’ vero, quelle “regolari” sono poche, le altre sono continuamente sotto la spada di Democle di qualche denuncia per irregolarità amministrative o per le denunce più fantasiose. Detto questo le nostre moschee, regolari e irregolari, sono tante, e sono perlopiù sottoutilizzate e spesso anche mal tenute. Nascono per la preghiera, certo, ma da sempre la moschea è altro. E’ lo spazio pubblico per eccellenza della cultura islamica. Dovrebbero essere – secondo la secolare tradizione islamica – centri di dibattito e di cultura, capaci di attirare un folto pubblico non solo di credenti. Sappiamo tutti quanto la realtà sia diversa (a parte virtuose eccezioni): chiuse su se stesse, dirette da piccoli gruppi autoreferenziali, raramente vi si parla italiano. Si mettono in mostra negli “open days” e negli iftar con le autorità o la cittadinanza, poi tornano a chiudersi su sé stesse, mentre potrebbero ospitare iniziative quotidiane ed essere luoghi di frequenza quotidiana. Luoghi in cui la domanda politica si articola e giunge a sintesi attraverso la pratica islamica della shura. Invece di farci intimidire dall’etichetta di “islam politico” dovremmo ricordarci il ruolo cruciale svolto dalle chiese evangeliche nella lotta contro il regime di apartheid in Sudafrica
La manifestazione del 12 aprile avrà raggiunto il suo scopo – la Palestina libera – se il giorno dopo ciascuno di noi, unendosi a due o tre fratelli, sorelle, amici, si impegnerà in uno qualsiasi di questi settori, in una qualsiasi delle possibili azioni concrete elencate (o anche altre), a tre condizioni: in modo stabile (senza mollare dopo un paio di mesi), in uno spazio fisico (non online), cercando di coordinarsi e cooperare con altri che fanno la stessa cosa (invece di considerarli istintivamente dei rivali). Ricordandoci che le azioni più amate da Allah sono quelle regolari e costanti, anche se piccole.”