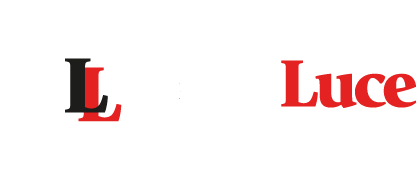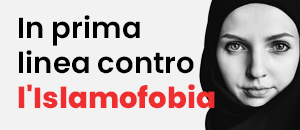Quando ci si imbatte in un prodotto di propaganda ben confezionato l’errore più grave è liquidarlo come “inutile chiacchiericcio”. La conferenza è del 26 Marzo con relatore David Elber e diffusa su YouTube da Amici di Israele il 2 Aprile 2025. La tesi di Elber – collaboratore fisso del sito L’Informale – non è una divagazione privata: è un intervento costruito con metodo per rovesciare il lessico dei diritti umani e ricondurre l’intera questione israelo-palestinese a un dogma giuridico selettivo.
L’Informale, nato nel 2015 per iniziativa di Riccardo Ghezzi e oggi diretto da Niram Ferretti – editorialista noto per una retorica da scontro di civiltà e islamofoba – si presenta esplicitamente come voce “diversa” nel panorama dell’informazione italiana: vuole «far conoscere Israele e le sue ragioni» e, per farlo, si vanta di ignorare la “politica interna” per concentrarsi sulla “realtà lontana ma centrale” del Medio Oriente. In pratica sostituisce l’approfondimento con un monologo ideologico.
Elber, laureato in Storia moderna a Milano, ha pubblicato per l’editore fiorentino Belforte tre volumi che ridisegnano il Mandato britannico come atto di trasferimento esclusivo di sovranità al popolo ebraico. Nella conferenza ripropone la stessa tesi, affiancandola a una carrellata di esempi disparati (decolonizzazione africana, Jugoslavia, Crimea) per dimostrare che Israele non occupa nulla e che i palestinesi sarebbero addirittura “coloni” in casa propria.
Sviscerare e confutare questo discorso, passo dopo passo, è necessario per due ragioni: innanzitutto, per restituire alla discussione i fondamenti reali del diritto internazionale – sovranità, occupazione, autodeterminazione, protezione delle popolazioni civili. Come secondo punto, lo scopo è disinnescare una macchina retorica che, dietro la patina accademica, legittima l’espropriazione del territorio palestinese e criminalizza ogni forma di resistenza.
Perché la conferenza è fanatismo ed il cavallo di Troia dell’uti possidetis juris
Fin dall’esordio Elber annuncia l’intenzione di ribaltare espressioni come territori occupati, colonie, apartheid, genocidio. Non si tratta di un esercizio filologico: è la premessa programmatica a un rovesciamento politico-morale che – se preso sul serio – trasforma la vittima in aggressore e immunizza lo Stato occupante da ogni responsabilità.
Quando l’oratore deride la definizione di apartheid come rovesciata completamente – perché, dice, che se esiste apartheid esso non è in Israele – cancella con un colpo di spugna lo Statuto di Roma (art. 7, par. 2-h) e due rapporti dell’Ufficio ONU per i Diritti Umani (2022, 2023) che descrivono il sistema di doppia legislazione in Cisgiordania come regime di segregazione razziale. Analogamente, ridefinendo il genocidio come progetto unilaterale di Hamas, elude la Convenzione del 1948 e gli obblighi di prevenzione che gravano sugli Stati, qualunque sia il comportamento di un gruppo armato non statale.
Il cuore dell’argomentazione ruota intorno all’uti possidetis juris. Elber lo presenta come un principio “universale” che congelerebbe le frontiere coloniali al momento della nascita di un nuovo Stato, legittimando retroattivamente l’annessione israeliana della Cisgiordania. Ma omette due elementi decisivi:
-
La stessa Corte Internazionale di Giustizia, nei casi Burkina Faso/Mali (1986) e Kosovo (2010), ha chiarito che l’uti possidetis tutela la stabilità solo in assenza di un conflitto armato d’occupazione e non prevale sul diritto di autodeterminazione;
-
Nel 1967 Israele non si trovò di fronte a un confine “amministrativo” ereditato dal Mandato, bensì a una linea d’armistizio riconosciuta internazionalmente, rispetto alla quale è – dal punto di vista giuridico – potenza occupante.
Con questo il delirio di Elber è già smontato. Ma la gravità del delirio rimane. Infatti, riducendo l’uti possidetis a passe-partout contro ogni rivendicazione palestinese, la conferenza si converte in un video-manuale di due ore sulla legittimazione dell’annessione permanente.
Per rafforzare la tesi, il relatore accosta la Palestina alla Craina serba, al Nagorno-Karabakh, alla Crimea: casi in cui, a suo dire, la comunità internazionale avrebbe ignorato l’autodeterminazione e sancito lo “status quo”. Gli esempi sono scelti a tavolino: Elber trascura che la Crimea è tuttora sotto sanzioni ONU e UE; che in Karabakh la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU ha sollecitato l’Azerbaigian a proteggere la popolazione armena; che la Craina fu riassorbita nella Croazia in esito a un accordo di pace firmato a Dayton. Gli accostamenti, insomma, servono solo a normalizzare l’idea che la forza crei diritto.
Infine, definendo gli abitanti arabi della Cisgiordania «comunità non ebraiche» prive di diritti politici (riprendendo selettivamente il Mandato del 1922), l’oratore sposta l’asse dal tema essenziale – l’autodeterminazione – a un dibattito antiquario su mappe e decreti coloniali. Il risultato è la negazione del popolo palestinese come soggetto di diritto, premessa indispensabile per rigettare ogni negoziato che contempli la fine dell’occupazione.
Che cos’è davvero l’uti possidetis juris?
Il principio cui David Elber affida la parte più ambiziosa della sua dimostrazione nasce molto lontano dalla Palestina. L’espressione uti possidetis appartiene al lessico romano («restate in possesso di ciò che occupate»), ma la versione moderna – uti possidetis juris – compare per la prima volta nelle dichiarazioni d’indipendenza ispano-americane di inizio Ottocento: i nuovi Stati vollero ereditare i confini dei viceroyatos spagnoli (definite anche come “límite del virreinato“) per evitare guerre fratricide. A metà Novecento l’Organizzazione dell’Unità Africana internalizzò lo stesso criterio per disinnescare le pretese territoriali che avrebbero potuto esplodere alla fine del colonialismo europeo.
Il testo classico è la sentenza Burkina Faso / Mali (1986). La Corte dell’Aja stabilisce che l’uti possidetis juris
«congela i confini amministrativi esistenti al momento dell’indipendenza, ma solo al fine di garantire la stabilità e senza pregiudicare il diritto di autodeterminazione» (parr. 23–25).
Di lì in poi il principio viene ribadito in Frontière terrestre et maritime Cameroun / Nigéria (2002) e, in forma indiretta, nell’Opinione Kosovo (2010): la Corte chiarisce che l’uti possidetis opera nel momento fondativo di uno Stato e serve a prevenire dispute frontaliere fra entità sorelle – non a legittimare l’acquisizione di territorio con la forza né a soffocare la volontà popolare.
Quattro condizioni sempre presenti:
-
Un’autorità sovrana riconosciuta dalla quale il nuovo Stato si distacca (Spagna, Francia, Gran Bretagna, ecc.).
-
Frontiere amministrative definite all’interno di quell’autorità (viceroyatos, colonie, repubbliche federate).
-
Dichiarazione d’indipendenza o dissoluzione consensuale che trasformi i confini interni in frontiere internazionali.
-
Assenza di occupazione militare esterna: la Corte precisa che il principio non sana l’usurpazione armata (Nicaragua / Colombia, 2012, par. 118).
Perché allora la Cisgiordania non rientra nello schema? I motivi sono principalmente tre:
Troviamo subito la mancanza del “momento fondativo”. Quando il Mandato britannico terminò (maggio 1948) non nacque uno Stato palestinese ma scoppiò una guerra. Israele dichiarò l’indipendenza dentro un perimetro approvato dall’ONU, la Giordania occupò la Cisgiordania, l’Egitto Gaza. L’assenza di un successore sovrano unificato rende inapplicabile l’uti possidetis. Le linee delineate inoltre erano di armistizio, e non confini amministrativi. Le famose Green Lines del 1949 non erano “frontiere interne” di un’entità precedente, bensì linee di cessate-il-fuoco negoziate post-bellum. La loro natura provvisoria è esplicitata in ciascun accordo di Rodi («non pregiudicano future sistemazioni territoriali»). Non bisogna poi dimenticarsi dell‘occupazione militare dal 1967, in quanto la mancata annessione formale da parte di Israele – unita al riconoscimento ONU del popolo palestinese come parte terza distinta – colloca la Cisgiordania nella categoria dei Territori Occupati disciplinati dall’art. 42 del Regolamento dell’Aja e dalla IV Convenzione di Ginevra. L’uti possidetis non è mai stato invocato con successo per “normalizzare” un’occupazione protratta; né lo è stato per il Sahara Occidentale, né per il Kuwait nel 1990, né per l’Ucraina orientale dopo il 2014.
Nella stessa sentenza Burkina Faso/Mali la Corte avverte che l’uti possidetis «non può essere invocato per negare o comprimere il diritto dei popoli a determinare liberamente il proprio destino» (par. 25). Questo diritto è scolpito nell’art. 1 comune ai Patti ONU sui diritti civili e sociali (1966) e riaffermato dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ris. 2625/1970). Chi lo derubrica a “chimera romantica”, come fa Elber, ribalta l’ordine gerarchico delle fonti: dal 1945 la tutela dei popoli sottoposti a dominazione straniera è parte dello jus cogens, cioè del nucleo inderogabile dell’ordinamento internazionale.
Se l’interpretazione proposta da Elber fosse corretta, gli stessi Stati che oggi occupano un seggio all’ONU avrebbero potuto appellarsi all’uti possidetis per legittimare:
-
L’annessione del Kuwait da parte dell’Iraq (1990): Bagdad sostenne che lo sceiccato era “parte storica” della provincia ottomana di Bassora. Il Consiglio di Sicurezza respinse la tesi e autorizzò l’uso della forza per ristabilire la sovranità kuwaitiana.
-
L’occupazione russa della Crimea (2014): Mosca citò la continuità zarista-sovietica, ma l’Assemblea Generale – ris. 68/262 – dichiarò nulla l’annessione.
In tutti questi casi la comunità internazionale ha preferito il binomio integrità territoriale + autodeterminazione all’ipotesi di cristallizzare i risultati di un’occupazione armata.
Tolte le condizioni strutturali, l’uti possidetis evocato dal relatore risulta un guscio privo di contenuto normativo. È, in sostanza un’anacronistica proiezione di logiche coloniali asimmetriche (la Gran Bretagna “cede” l’intero Mandato a una sola collettività, cancellando l’altra). Ci troviamo anche davanti ad un cortocircuito logico che pretende di tramutare in confini “ereditati” ciò che era – al massimo – un confine esterno di potenze terze (l’Impero Ottomano prima, la Giordania poi). Questa forzatura storica lascia intendere che l’ONU avrebbe violato il proprio statuto riconoscendo la Palestina, quando è vero l’esatto contrario – è l’ONU ad aver internazionalizzato la questione sin dal 1947 proprio per salvaguardare l’autodeterminazione di entrambi i popoli.
Il Mandato britannico: come Elber trasforma un testo di tutela bilaterale in un atto di trasferimento esclusivo di sovranità
Ogni volta che il dibattito sull’occupazione rischia di tornare alla realtà – confini del ’67, Convenzioni di Ginevra, risoluzione 2334 – l’oratore compie un balzo all’indietro e richiama il Mandato per la Palestina (1922). Secondo la sua ricostruzione, quel documento «assegna in modo inequivocabile» tutta la Palestina storica al popolo ebraico, mentre le comunità arabe sarebbero semplici “popolazioni non-ebraiche” senza diritti politici.
Per sostenere l’affermazione Elber isola poche righe del preambolo e dell’art. 6, omettendo l’altra metà del contratto: la parte che imponeva al Mandatario l’obbligo – cito – di «non compiere nulla che possa pregiudicare i diritti civili e politici delle popolazioni non-ebraiche».
Il passaggio chiave è l’articolo 2. Dopo aver richiamato la Dichiarazione Balfour, il testo prosegue:
«Il Mandatario sarà responsabile … di assicurare che non sia fatto nulla che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non-ebraiche esistenti in Palestina, né i diritti e lo status politico di qualunque altro Paese.»
Con tutte le dovute delegittimazioni della Dichiarazioni Balfour, comunque la distinzione fra diritti civili-religiosi (alle comunità interne) e status politico (ai loro Paesi d’origine) era una clausola pensata per un territorio multi-etnico in cui la maggioranza della popolazione, all’epoca, era araba. Eliminare quell’inciso – come fa il relatore – significa negare la natura bilaterale dell’incarico affidato alla Gran Bretagna.
Ancora più esplicito è l’articolo 22 dello Statuto della Società delle Nazioni, la base giuridica di tutti i mandati: esso definisce le ex colonie ottomane «popolazioni i cui stadi di sviluppo permettono il riconoscimento come nazioni indipendenti», subordinando la presenza della potenza mandataria al solo scopo di accompagnarle verso istituzioni di autogoverno. Questa traiettoria coinvolgeva tutti gli abitanti del territorio, non una parte soltanto.
Elber cita l’art. 25 del Mandato per la Palestina per sostenere che la Gran Bretagna avrebbe sospeso l’applicazione della Balfour a est del Giordano, ma sorvola sul motivo: Londra temeva un conflitto etnico già allora innescato dall’immigrazione europea, e scelse di regolare i flussi. Nel White Paper di Churchill (1922) – coevo al Mandato – si legge infatti:
«L’insediamento ebraico non deve oltrepassare la capacità economica del Paese di assorbirlo senza ledere la popolazione esistente.»
La citazione smentisce l’idea di un diritto illimitato di colonizzare “terre demaniali”: sin dall’inizio Londra poneva un tetto in funzione degli effetti sociali sugli arabi residenti.
Fra il 1922 e il 1939 l’immigrazione ebraica fu regolata da un sistema di certificati concordato con l’Agenzia Ebraica. Quando la tensione esplose nella rivolta palestinese del ’36-’39, la Gran Bretagna emanò un nuovo Libro Bianco che ridusse a 75 000 ingressi il contingente quinquennale e propose uno Stato binazionale per fine decennio. Elber non menziona né l’una né l’altra misura, perché contraddicono l’immagine di un Mandato inteso come “patente di esclusiva sovranità”.
Anche se accettassimo – per assurdo e contro la lettera del testo – che il Mandato consegnasse la Palestina integralmente «al popolo ebraico», ciò non cambierebbe di un millimetro la qualificazione giuridica dell’assetto nato dopo il 1967. Il Mandato è un titolo storico; l’occupazione è una situazione di fatto regolata dal diritto bellico contemporaneo (Convenzione dell’Aja 1907, IV Ginevra 1949, Protocollo I 1977). La pretesa di far valere un “marchio di proprietà” coloniale per neutralizzare le norme posteriori viola il principio di successione cronologica delle fonti: una regola antica non abroga una più recente (lex posterior derogat priori).
Una volta indebolito il Mandato fino a trasformarlo in atto di proprietà esclusiva, la conferenza di Amici di Israele affronta il passaggio successivo: dissolvere la distinzione fra linee d’armistizio del 1949 e frontiere. Elber invita il pubblico a «scordarsi della risoluzione 181» perché «non ci sono mai stati confini», e definisce le Green Lines «righe tirate su un foglio» disegnate con una penna verde. Il messaggio è chiaro: se quei tratti di matita sono nati provvisori, resteranno provvisori per l’eternità, e nessuno potrà mai accusare Israele di averli oltrepassati.
“Non sono confini, quindi non valgono”: la fallacia logica
Finita la guerra del 1948, Israele firmò con ciascuno dei Paesi arabi un Accordo generale d’armistizio. Come ricorda di continuo la letteratura giuridica, un armistizio sospende le ostilità ma non le conclude: i confini definitivi devono essere stabiliti per via diplomatica. È corretto, dunque, affermare che la Green Line non era – e non è – de jure frontiera internazionale. Proprio per questo, però, l’integrità del territorio dietro quella linea resta intatta finché non intervenga un trattato di pace. Lo diceva già l’articolo 2 della Carta ONU (divieto di acquisizione di territorio con la forza) e lo riaffermò, vent’anni dopo, il Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 242/1967: Israele avrebbe dovuto ritirarsi «da territori occupati» in cambio della fine dello stato di guerra.
L’oratore si affida a un sofisma: poiché le linee di Rodi non sono frontiere definitive, allora non valgono nemmeno come limite provvisorio. È l’esatto contrario. Proprio perché la linea non è stata mai sostituita da un confine pattizio, essa rimane l’unico riferimento giuridico valido. Chi attraversa la Green Line con truppe e civili non trasferisce un confine: crea un’occupazione – situazione riconosciuta come tale dal CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa), dal Segretariato ONU e, soprattutto, dal Consiglio di Sicurezza (risoluzioni 267/1969, 298/1971, 2334/2016).
Nel 1974, rispondendo all’annessione israeliana di Gerusalemme Est, la Corte Suprema USA (caso Zivotofsky) trattò la Green Line come limite che il potere esecutivo statunitense non poteva ignorare senza violare la politica di non-riconoscimento. Non è un dettaglio: persino l’alleato più stretto di Israele considera la sovranità oltre la linea né stabilita né legittima.
Elber descrive poi la guerra dei Sei giorni come se avesse azzerato la mappa: «Israele eredita tutto il Mandato»; perciò non c’è occupazione. Ma il diritto internazionale, dal 1949 in poi, distingue nettamente due categorie: territorio proprio e territorio occupato. All’alba del 5 giugno 1967 la Cisgiordania non era area di sovranità israeliana; lo dicono:
-
La lettera del ministro degli Esteri Eban al Segretario generale (4 giugno 1967);
-
La “Blue Line” della stessa IDF – cartografia militare che segnava la Giudea-Samaria come area esterna allo Stato ( la linea interna di pianificazione militare non è pubblicata ma la citazione è ricorrente in studi accademici.
-
Il rapporto del 1968 dell’avvocatura israeliana (Memorandum Sasson), che riconosce l’applicabilità dei Regolamenti dell’Aja all’amministrazione militare dei Territori.
Se Israele stesso qualificò quei territori occupati, farlo oggi non è un atto politico, ma la semplice continuità di un dato giuridico.
C’è un punto ulteriore che la delirante conferenza non nomina mai: la più recente risoluzione vincolante sul tema, la 2334 del dicembre 2016. Votata con l’astensione USA, afferma che «le attività di insediamento non hanno validità legale e costituiscono flagrante violazione del diritto internazionale»; ribadisce la distinzione pre-1967 / post-1967 e chiede a tutti gli Stati di «differenziare, nei loro rapporti, il territorio dello Stato di Israele e i Territori Occupati». Se, come pretende Elber, non esistesse alcuna frontiera da rispettare, la risoluzione sarebbe tecnicamente impossibile: ma la risoluzione esiste e lega – ex art. 25 Carta ONU – tutti i membri, Italia compresa.
Resta dunque la domanda: che cos’è un confine nel 2025? Il confine non è solo una linea fisica; è riconoscimento reciproco. Israele ha confini riconosciuti con Egitto e Giordania perché due trattati di pace (1979, 1994) lo consacrano. Non li ha con Libano, Siria e Palestina perché quei trattati non esistono. Finché l’accordo manca, l’unico spartiacque valido resta l’armistizio del ’49. Rifiutarlo significa proclamare che il mondo intero non ha alcun titolo per opporsi a cambi di sovranità armati – un ritorno al peggiore diritto dei cannoni, che la Carta ONU ha seppellito circa ottant’anni fa.
Insediamenti, “terre demaniali” e l’articolo 49(6): anatomia di una falsificazione
Il punto in cui la conferenza di David Elber rinuncia a ogni cautela rimarcando i caratteri genocidari è la giustificazione delle colonie israeliane in Cisgiordania. Con un rovesciamento semantico da orrore l’oratore afferma che gli unici «coloni» sarebbero gli arabi che costruiscono villaggi nell’area C, mentre gli ebrei insediatisi oltre la Green Line sarebbero semplicemente «israeliani che vivono in territorio a esclusivo controllo israeliano». Il passaggio chiave è l’idea che le nuove abitazioni sorgano su terre demaniali vacanti e dunque non violino alcun divieto internazionale. Il discorso procede in tre mosse:
Il primo è trasformare i “Territori Occupati” in “Territori Amministrati” – se non c’è occupazione, non c’è potenza occupante del resto;
Il secondo, è qualificare la superficie non registrata come “State land” di proprietà israeliana;
Infine, si negare la portata dell’articolo 49(6) della IV Convenzione di Ginevra, che vieta alla potenza occupante di trasferire la propria popolazione civile nel territorio occupato.
La IV Convenzione, ratificata da Israele nel 1951, sancisce che «la Potenza occupante non deporterà né trasferirà parte della propria popolazione civile nel territorio da essa occupato». Gli autori dei Commentari ufficiali (Pictet 1958; ICRC 2020) spiegano che «trasferire» significa incoraggiare, organizzare o agevolare lo spostamento di civili, indipendentemente dal metodo. La norma è oggi incorporata nello Statuto della Corte penale internazionale (art. 8(2)(b)(viii)) come crimine di guerra. Non è mai esistita una clausola che subordini il divieto all’esistenza di proprietari privati: ciò che conta è la natura del territorio – occupato – e la nazionalità dei civili immessi.
Il relatore riprende la tesi elaborata negli anni Ottanta dall’allora procuratore Avraham Sasson: in assenza di titolo catastale ottomano, un terreno è “mulk saltani” (demanio) ed entra nel patrimonio dello Stato d’Israele quale successore legale dell’esercito. Dal 1979 la stessa Corte Suprema israeliana ha però circoscritto quella dottrina:
Nella causa Elon Moreh vs. Ministro della Difesa (HCJ 390/79), ad esempio la Corte ha annullato la requisizione di terra privata a fini di colonia civile. Vi è poi la sentenza Peace Now vs. Ministro delle Costruzioni (HCJ 7891/02) in sui chiede al governo di provare il carattere pubblico del suolo. un terzo esempio è quello del 2014 (caso Alon Shevut) in cui la Corte ha riconosciuto che la procedura di dichiarazione di state land non può prescindere da un esame effettivo dell’uso agricolo palestinese.
Persino gli organi giudiziari interni dell’entità occupante, dunque, ammettono che la maggior parte degli avamposti israeliani include porzioni di proprietà privata o di terre di villaggio tradizionalmente utilizzate, annodando la pratica coloniale al land grab.
A partire dal 1968 il Consiglio di Sicurezza qualifica gli insediamenti come «senza alcuna validità giuridica» (res. 252, 267, 446, 476, 478, 2334). Il Segretariato ha poi chiarito (Memo L/ES-10/17, 2001) che l’art. 49(6) della IV Convenzione di Ginevra – che vieta alla Potenza occupante di trasferire la propria popolazione civile nel territorio occupato – è norma di ius cogens: gli Stati non possono accordarsi per derogarla, men che meno farlo unilateralmente proclamando il terreno «demaniale» (o state land, bene immobile appartenente allo Stato). Elber tacita l’intero corpus, fingendo che l’unico test internazionale sia la sua lettura del Mandato del 1922, indice questo di ignoranza oltre che di disonestà. Oltre al corpus, parlano i numeri (che il video non mostra):
-
Più di 700 000 coloni israeliani vivono oggi oltre la Green Line; di questi, circa 500 000+ in Cisgiordania e 200 000+ a Gerusalemme Est (Israeli CBS, 2024).
-
La costruzione di infrastrutture per soli israeliani ha frammentato la Cisgiordania in 165 “isole” palestinesi (OCHA oPt, Fragmentation Map, 2023).
-
Fra il 1994 (pace con la Giordania) e il 2024 la popolazione coloniale è raddoppiata, nonostante gli Accordi di Oslo qualificassero l’Area C come temporanea sotto controllo israeliano in attesa di status talks definitivi.
Ignorare queste cifre consente a Elber di parlare di «macchioline blu» marginali; ma la superficie urbanizzata degli insediamenti, compresi i corridoi di sicurezza, supera ormai il 10 % della Cisgiordania, e l’Area C – indispensabile per lo sviluppo palestinese – rappresenta da sola il 60 % del territorio occupato. Non si dovrebbe dunque parlare di «macchioline blu» marginali, ma di macchia nera Israeliana in territorio Palestinese.
L’argomento ridicolo dei “beduini illegali” ed il caso di Masafer Yatta
Quando Elber definisce Masafer Yatta un «assembramento abusivo di lamiere senza fogne» finanziato dall’UE, rovescia la sentenza della stessa Alta Corte israeliana (HCJ 953/21): in quel procedimento i magistrati hanno accettato la linea militare secondo cui l’area sarebbe “zona di tiro”, e ha accolto la posizione militare secondo cui l’area non ospitava insediamenti stabili prima degli anni settanta nonostante le prove archeologiche, ritenendo dunque le espulsioni dei palestinesi compatibili col diritto bellico e respingendo i ricorsi dei residenti. L’etichetta di “abusivo” da parte di Elber nasce da un doppio vincolo: negazione sistematica dei permessi di costruzione ai palestinesi + progettazione autarchica delle colonie ebraiche adiacenti (Carmel, Avigayil, Ma’on). In altre parole, il “vuoto demografico” che Elber vede è il risultato di un meccanismo di esclusione, non di una naturale assenza di insediamenti arabi. La sentenza dunque smentisce l’idea di Eber secondo cui la proprietà privata a Masafer Yatta non venga «toccata» dimostrando la “doppia legge” che vive in Cisgiordania, e confermando il trasferimento forzato denunciato dai vari organi internazionali.
In uno dei momenti più ideologici della conferenza David Elber afferma che «se esiste un apartheid, non è in Israele ma nel resto del Medio Oriente». Con questa battuta liquida una questione che dal 2021 occupa dossier, rapporti giuridici e sentenze in mezza dozzina di fori internazionali. Per capire perché la battuta è fuorviante occorre passare dalla caricatura alla definizione di diritto.
Il termine apartheid non appartiene solo alla memoria sud-africana: è voce normativa in due strumenti vincolanti:
-
Convenzione ONU sull’eliminazione del crimine di apartheid (1973), art. II:
«qualsiasi atto compiuto con lo scopo di istituire e mantenere la dominazione di un gruppo razziale su un altro e di opprimerlo sistematicamente».
-
Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998), art. 7(2)(h):
«pratiche inumane di carattere analogo ad altri crimini contro l’umanità compiute nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione e dominazione sistematica».
Tre sono dunque gli elementi costitutivi:
(1) due gruppi razziali/etno-nazionali; (2) dominazione sistemica e istituzionalizzata; (3) atti inumani destinati a mantenere tale dominazione.
Immaginiamo un territorio dove due persone possono abitare la stessa collina, percorrere la stessa strada e usare la stessa lingua, ma al calare del sole finiscono sotto codici giuridici incompatibili: l’una vive da cittadina piena, tutelata da tribunali civili, urbanistica pianificata, libertà di movimento; l’altra ricade in un universo di ordini militari, permessi negati e posti di blocco. È proprio questa architettura a “doppia corsia”—una per gli israeliani, una per i palestinesi—che fa parlare di regime di separazione razziale. Ecco come funziona, nei fatti quotidiani:
| Ambito | Regime applicato ai coloni israeliani | Regime applicato alla popolazione palestinese | Fonte indicativa |
|---|---|---|---|
| Statuto giuridico | Diritto civile israeliano ordinario per ≈ 480 000 coloni | Legislazione d’emergenza militare (Ordini del Comando Centrale 1967-2024) per ≈ 3 milioni di palestinesi | Raccolta ordini IDF, 1967-2024 |
| Movimento e accesso al territorio | Strade di bypass, check-point “solo israeliani”; libertà di circolazione interna | 165 “isole” palestinesi frammentate, transito subordinato a permessi e controlli | OCHA-oPt, Fragmentation Map 2023 |
| Pianificazione urbana / edilizia | Iter edilizio civile; ampliamento continuo dei blocchi colonici con procedure accelerate | Nell’Area C (60 % del territorio) solo 1,5 % destinato a sviluppo palestinese; tasso di permessi < 2 %; demolizioni per “costruzione senza licenza” | B’Tselem, Under the Guise of Legality 2019 |
| Giustizia penale e custodia cautelare | Processi in tribunali civili israeliani (es. Gerusalemme); garanzie procedurali piene | Processi in corti militari (es. Ofer); detenzione preventiva prolungata, garanzie limitate | Statistiche sistema giudiziario IDF |
Il criterio differenziale non è religioso né “cittadinanza” in astratto: è l’appartenenza nazionale/etnica, cioè l’esatto perimetro che le convenzioni sul crimine di apartheid intendono colpire.
Nessuno di questi organismi inserisce la parola “apartheid” come insulto politico: la usa come qualificazione giuridica secondo gli strumenti ratificati da Israele o comunque obbligatori (ius cogens).
Elber liquida l’accusa di apartheid con tre slogan-chiave. Vale la pena richiamarli in ordine, così da smontarli alla luce delle norme internazionali – indicando per esteso gli strumenti giuridici, non con sigle ellittiche.
Primo slogan: «Gli arabi israeliani votano in parlamento, quindi l’apartheid è impossibile».
L’apartheid non dipende dall’assenza totale di diritti civili; ciò che conta è l’istituzione di un regime di dominazione sistemica basato sull’appartenenza etnico-nazionale. Lo spiega l’International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (ONU, 30 novembre 1973, art. II): sono vietate «pratiche inumane commesse allo scopo di instaurare e mantenere la dominazione di un gruppo razziale su un altro». Nel Sudafrica degli anni Sessanta esistevano Bantustan con un limitato diritto di voto per i neri, eppure il sistema rimaneva apartheid – esempio citato dalla stessa Commissione d’inchiesta ONU (Rapporto A/HRC/4/48, 2007). Il fatto che alcuni cittadini palestinesi d’Israele siedano alla Knesset non incide sulla realtà, nei Territori Occupati, di due regimi giuridici separati.
Secondo slogan: «I beduini di Masafer Yatta vivono in baracche abusive; prima del 1999 lì non c’era nulla».
Anche se fosse vero – e non lo è – il diritto umanitario protegge le popolazioni presenti al momento dell’occupazione. La IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, art. 49, comma 1 vieta il trasferimento forzato di «persone protette» dal loro territorio, indipendentemente dall’esistenza di un titolo di proprietà registrato; lo status di «villaggio non riconosciuto» è il prodotto di un sistema di pianificazione che, da decenni, rifiuta sistematicamente i permessi edilizi ai palestinesi (dati official IDF Civil Administration 2016-2022). Spostare la colpa sulla datazione delle baracche equivale a invertire causa ed effetto.
Terzo slogan: «Gli insediamenti coprono solo il 10 % della Cisgiordania: troppo poco per parlare di apartheid».
Il crimine non richiede una “copertura territoriale omogenea”: basta che esista una suddivisione stabile di diritti e accessi in base all’identità etnico-nazionale. Nel Sudafrica degli anni ottanta i Bantustan occupavano meno del 20 % del territorio, ma la International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid li considerava parte integrante del regime. Oggi, sebbene l’area urbanizzata dei blocchi colonici equivalga a circa il 10 %, la relativa zona di giurisdizione (incluse le riserve di espansione e i corridoi di sicurezza) supera il 40 % della Cisgiordania; quel mosaico di divieti e permessi basta, per gli studiosi di diritto internazionale e per i rapporti ONU 2022-2023, a configurare un “regime istituzionalizzato di dominazione” – esattamente la definizione di apartheid contenuta nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, art. 7, par. 2-h (1998).
Elber passa anche a definire «apartheid arabo» la mancanza di libertà religiosa in Libano o Arabia Saudita con l’intento di sviare l’attenzione: le violazioni di quei regimi non cancellano né attenuano il regime di separazione imposto in Cisgiordania. È la stessa logica esibita dai governi dell’apartheid sud-africano negli anni Settanta: puntare il dito su violazioni altrove per legittimare il proprio sistema duale. La comunità internazionale non accettò allora l’argomento; non lo accetta oggi.
Questo approccio è simile a quando Elber spende interi minuti per dimostrare la “differenza morale” fra Israele e Hamas. Israele, afferma, «avvisa sempre con volantini e SMS prima di bombardare, fa di tutto per evitare vittime civili»; Hamas, al contrario, prenderebbe deliberatamente di mira i civili. La conclusione implicita è che i primi siano immuni da accuse di crimini di guerra. Il ragionamento, tuttavia, trascura l’architettura completa del diritto internazionale umanitario (IHL) e misconosce il significato tecnico di “precauzioni in attacco”.
L’articolo 57 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra impone tre obblighi cumulativi agli attaccanti: verifica dell’obiettivo, scelta dei mezzi per minimizzare i danni collaterali, avviso effettivo e tempestivo quando possibile. L’avviso, dunque, non sostituisce le altre due condizioni: deve accompagnarle. La Corte internazionale di giustizia lo ribadì nell’Opinione Nuclear Weapons (1996, par. 78): «nessuna precauzione preventiva dispensa dall’obbligo generale di distinzione e proporzionalità». Se fosse questo il caso, un avvertimento con volantini avrebbe esonerato da ogni colpa gli USA nel contesto del bagno di sangue di Hiroshima e Nagasaki. Non molti sanno infatti che gli Stati Uniti diffusero volantini sul Giappone nelle ultime settimane di guerra. Dal giugno 1945 le squadriglie B-29 del 20th Air Force sganciarono milioni di “LeMay leaflets” – così chiamati dal generale Curtis LeMay – per avvertire che diverse città sarebbero state bombardate a breve. Tra il 27 e il 30 luglio fu distribuito un volantino che elencava anche Hiroshima e Nagasaki fra i dodici capoluoghi a rischio. Il 6 agosto la bomba atomica fu lanciata su Hiroshima; anche se i primi fogli che menzionavano la “nuova bomba” comparvero solo l’8–9 agosto, quando la città era già distrutta. Lo stesso schema si ripeté a Nagasaki: lo strike del 9 agosto arrivò senza pre-allarme specifico, e i volantini che descrivevano l’ordigno vennero dispersi solo a cose fatte (10-12 agosto). Questi leaflets assumevano in questo modo più un ruolo di arma psicologica che di avvertimento, ragion per cui basarsi su tutti e tre i principi dell’articolo 57 del I Protocollo è conditio sine qua non.
Quando l’avvertimento è generico, o troppo ravvicinato, o indirizzato a persone impossibilitate a muoversi (anziani, disabili, pazienti ospedalieri), non soddisfa il requisito di effettività. La Relatrice speciale ONU sulle esecuzioni extragiudiziali, Agnès Callamard, lo ha ricordato dopo gli attacchi a Gaza del 2021: «l’avvertimento non può trasformare un ospedale in obiettivo legittimo».
Inoltre, dal 2009 l’IDF applica la roof-knocking doctrine: un proiettile a bassa carica colpisce il tetto come segnale di sgombero, seguito da munizione vera. Uno studio indipendente (Emanuela Chiara Gillio, Distinctive Warnings?, 2019) mostra che il tempo medio fra i due colpi è spesso inferiore ai 5 minuti, insufficiente a evacuare un edificio alto o un complesso residenziale affollato. Il CICR, in un meeting of experts del 2018, ha indicato 15 minuti quale soglia minima “orientativa” per rendere l’avviso realmente efficace.
Anche ammettendo per assurdo un avviso valido, l’attaccante deve dimostrare che il danno collaterale previsto non superi, in relazione, il vantaggio militare concreto e diretto. La Commissione d’inchiesta ONU su Gaza (rapporto A/HRC/12/48, 2009, parr. 531-550) concluse che la distruzione sistematica di edifici governativi o residenziali, anche previa telefonata, mancava di vantaggio davvero “diretto” poiché Hamas poteva ripristinare funzioni di comando in poche ore. La stessa analisi è stata riproposta da Human Rights Watch e Amnesty per le operazioni “Guardian of the Walls” (2021) e “Swords of Iron” (2023-24).
Nel discorso di Elber scompare anche l’intero capitolo degli obiettivi a doppio uso (centrali elettriche, reti idriche, edifici di telecomunicazione). L’art. 52(2) del I Protocollo consente di colpirli solo se contributo militare concreto e vantaggio definito sono superiori al danno civile atteso. Tagliare la sola centrale di Shujaiyya, per esempio, comporta la sospensione delle pompe d’acqua per 200 000 persone: il bilancio non può essere derubricato con la formula “avvisiamo, quindi è lecito”.
Nel caso Targeted Killings (HCJ 769/02, 2006) il giudice Barak stabilì che perfino durante un conflitto armato, ogni attacco contro persona sospetta richiede valutazione individuale e revisione post-strike. In Al Mezan vs. Minister of Defence (HCJ 3261/06, 2007) – ricorso sui bombardamenti di Beit Hanoun – la Corte chiese un esame interno poiché dubitava che il principio di proporzionalità fosse rispettato, nonostante gli avvisi sonori lanciati con altoparlanti. L’esempio dimostra che, persino secondo il diritto interno israeliano, l’avvertimento non genera immunità.
Dopo il 7 ottobre 2023 più di un milione di gazawi sono stati spinti verso la striscia meridionale da messaggi di evacuazione. Le stesse forze israeliane hanno però continuato a colpire Rafah, Deir al-Balah e Khan Younis, rifugi teoricamente “sicuri”. Il quadro ricorda la sentenza ICTY, Kupreškić (2000): il Tribunale incriminò i leader croati per bombardamenti deliberati su civili preventivamente raggruppati in corridoi “raccomandati” dagli aggressori; l’avvertimento, affermò la corte, «non può trasformare la deportazione forzata in legittima misura di precauzione».
Per dimostrare che il mondo avrebbe già “ratificato” la regola «prendi e tieni», David Elber arruola tre scenari: la Craina serbo-croata (1991-95), la Crimea (2014) e il Nagorno-Karabakh (1988-2023). L’argomento è semplice: in tutti e tre i casi – sostiene – la comunità internazionale avrebbe congelato i risultati di una conquista di fatto, dunque non ci sarebbe ragione di trattare diversamente Cisgiordania e Gerusalemme Est. In realtà, se questi esempi li si guarda interi e non in “grandangolo selettivo”, producono l’effetto opposto: mostrano che il diritto internazionale considera illegittima l’acquisizione di territorio con la forza e che l’uti possidetis viene applicato contro chi tenta di spezzarlo con armi o pulizie etniche.
Quanto alla Jugoslavia, nel 1991 la Commissione Badinter dichiarò che i confini interni delle repubbliche diventavano automaticamente frontiere internazionali. Quando i miliziani serbi crearono la “Repubblica di Craina”, nessuno la riconobbe; anche dopo la cruenta Operazione Storm del 1995 la comunità internazionale ribadì che la fascia dalmata apparteneva alla Croazia. L’uti possidetis servì a difendere la carta repubblicana, non a premiarne la violazione.
Nel 2014 la Russia occupò la Crimea e organizzò un referendum lampo. L’Assemblea generale reagì con la risoluzione 68/262: annessione «null and void»; confini ucraini 1991 confermati; e raffica di sanzioni. Chi invoca qui l’uti possidetis è Mosca; la risposta del diritto è invece il divieto di acquisire territorio con la forza.
Sul caso del Nagorno-Karabakh, negli anni ’90 le truppe armene conquistarono la regione; quattro risoluzioni del Consiglio di Sicurezza la etichettarono come “territorio azero occupato”. Nel 2020-23 l’Azerbaigian ha riassorbito quasi tutto il Karabakh, ma nessuno, né prima né dopo, ha messo in discussione i confini sovietici del 1991: l’uti possidetis caucasico è rimasto la linea guida, indipendentemente da referendum o vittorie militari.
In tutti e tre i casi la comunità internazionale è partita da una foto anteriore all’uso della forza – confini repubblicani jugoslavi, frontiere sovietiche del 1991, mappe amministrative azere – e l’ha eretta a riferimento legale. Le offensive che alterano quella foto non cambiano il diritto, anche quando riescono militarmente. Inoltre, eventuali cambi di confine richiedono l’accordo formale fra Stati interessati, non la semplice “presa di possesso”.
Applicare il medesimo criterio alla situazione israelo-palestinese significa riconoscere il territorio oltre la Green Line come non israeliano fino a trattato di pace; ed è precisamente la posizione di quasi vent’anni di Consiglio di Sicurezza, culminata nella risoluzione 2334/2016.
In filigrana di tutta la conferenza corre un’altra operazione linguistica: far coincidere la critica alle politiche israeliane con un atteggiamento ostile verso gli ebrei in quanto tali. Elber non pronuncia mai apertamente la parola “antisemitismo”, ma il sottotesto affiora ogni volta che liquida la risoluzione 2334 come frutto di «ossessione anti-israeliana», o che descrive la schiera delle ONG per i diritti umani come «propaganda antisionista». L’equazione è efficace sul piano retorico—chi vorrebbe finire sul banco degli imputati del pregiudizio razziale?—ma giuridicamente e storicamente non regge.
Tirare le somme: perché l’impianto di Elber crolla – e cosa serve al dibattito pubblico
Arrivati alla fine del percorso, il mosaico genocidario di argomenti proposto da David Elber si rivela un castello di carte: ogni tassello, esaminato nel suo contesto autentico, contraddice la pretesa di legittimare l’annessione e di immunizzare Israele da qualunque obbligo verso i palestinesi.
| Nodo decisivo | Tesi di Elber | Dato giuridico/storico reale |
|---|---|---|
| Mandato 1922 | Trasferisce integralmente la sovranità al “popolo ebraico”. | Impone un doppio binario: costruzione della casa nazionale e tutela dei diritti politici arabi. |
| Uti possidetis juris | Congela per sempre le frontiere coloniali a favore di Israele. | Vale solo al momento fondativo di uno Stato, non legittima l’occupazione post-1967, non prevale sull’autodeterminazione. |
| Green Line 1949 | «Riga di matita», mai confine. | Resta il limite legale finché non intervenga un trattato; oltre la linea vige lo status di territorio occupato. |
| Insediamenti | Leciti su “demanio” ebraico; i veri coloni sono i palestinesi. | Vietati dall’art. 49(6) IV Ginevra; condannati da CS ONU 2334/2016; giudicati crimine di guerra dallo Statuto di Roma. |
| Apartheid | Fenomeno impossibile in Israele, presente solo nei Paesi arabi. | Definito da Convenzione 1973 e Statuto CPI; quattro rapporti ONU 2021-23 identificano elementi di apartheid nei T.O. |
| Avvisi prima dei raid | Rimozione di ogni responsabilità: «bombardamento umanitario». | Precauzione ≠ licenza; restano proporzionalità e distinzione (artt. 51-57 I Prot. Ginevra). |
| Paragoni (Craina, Crimea, Karabakh) | Precedenti che “normalizzano” l’annessione. | Tutti confermano il divieto di acquisire terra con la forza; sanzioni e risoluzioni difendono l’integrità territoriale. |
| Critica = antisemitismo | Ogni denuncia dell’occupazione è odio antiebraico. | IHRA distingue critica legittima da incitamento; CEDU tutela boicottaggi politici; JDA ribadisce la separazione concettuale. |